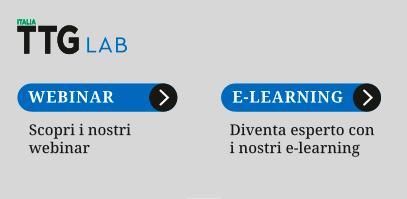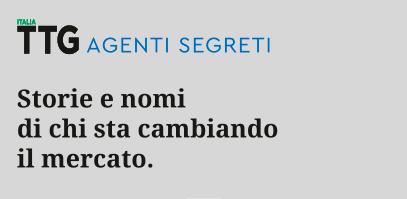Il 2026 si apre con un pacchetto di novità fiscali che, se lette con attenzione, possono trasformarsi da semplice adempimento normativo a leva concreta...

La legge di bilancio dello Stato per il 2026 in discussione in questi giorni porta con sé una stretta significativa sugli “affitti brevi” (ne parliamo qua): il testo predisposto dal governo prevede di eliminare alcune agevolazioni e di uniformare la tassazione, portando la cedolare secca sulle locazioni turistiche e sugli affitti brevi verso una aliquota del 26% (o comunque aumentando il campo di applicazione dell’aliquota più alta rispetto al 21% oggi riservato a certi casi) ed ha scatenato immediatamente proteste del comparto e divisioni interne alla maggioranza.
Dietro questa misura ci sono sia ragioni di cassa che obiettivi politici ed economici più ampi.
Sul piano fiscale, il governo mira a incrementare le entrate nel quadro di una manovra complessa e a semplificare il settore: uniformare le aliquote riduce le elusioni e richiude spazi normativi usati per ottimizzazioni fiscali.
Dal punto di vista delle politiche abitative, la scelta risponde anche alla pressione pubblica sulle città turistiche: limitare la redditività degli affitti brevi è visto come un modo per disincentivare la conversione massiva di case in alloggi temporanei e favorire il ritorno all’affitto di lungo periodo.
Gli effetti sociali ed economici che gli affitti brevi hanno prodotto negli ultimi anni sono però più complessi e spesso contraddittori.
Da una parte le piattaforme e i proprietari sostengono che l’offerta di locazioni turistiche ha generato indotto per le città: turismo diffuso, redditi per famiglie e micro-imprese, posti di lavoro collegati ai servizi e ricadute sui consumi locali. Studi commissionati a livello europeo evidenziano un contributo economico rilevante dell’economia degli affitti brevi al PIL e all’occupazione dei paesi UE. Dall’altra, ricerche accademiche e report indipendenti segnalano invece impatti negativi sull’offerta abitativa e sui prezzi: analisi su contesti urbani italiani mostrano una correlazione significativa tra diffusione degli annunci per affitti brevi e aumento dei prezzi di vendita e degli affitti: la trasformazione di appartamenti residenziali in alloggi temporanei sottrae casa al mercato locativo tradizionale e può spingere verso l’aumento dei canoni e dell’instabilità abitativa, soprattutto nelle zone centrali e maggiormente attrattive per i turisti. Il risultato sono tensioni sociali — dal calo di residenti storici alla perdita di servizi di quartiere — che le amministrazioni locali tentano di contrastare con regolamentazioni e limiti.
La concorrenza con il settore alberghiero è un altro elemento del dibattito: gli operatori tradizionali lamentano una competizione spesso non paritaria, soprattutto quando gli affitti brevi operano senza le stesse regole (norme di sicurezza, tassazione, oneri locali). Per questo il governo e molte amministrazioni locali vedono nella riforma fiscale uno strumento per riequilibrare il mercato e per far concorrere su basi comparabili strutture ricettive diverse.
Le conseguenze pratiche del rialzo fiscale saranno quindi miste: da una parte una possibile riduzione dell’offerta di affitti brevi nei centri più cari e una riqualificazione di immobili verso locazioni più stabili; dall’altra un rischio di ripercussioni sul turismo non tradizionale e di spostamento di quote di domanda verso formule meno regolate o verso mercati esteri.
Sicuramente però, se l’aumento della tassazione non sarà accompagnato da misure mirate per il mercato immobiliare (incentivi per l’edilizia residenziale pubblica, agevolazioni per locazioni a medio-lungo termine, controlli sulle pratiche di intermediazione), il risultato potrebbe limitarsi a una redistribuzione dei redditi e a tensioni politiche senza risolvere il problema strutturale della carenza di abitazioni accessibili.
In conclusione, la stretta fiscale sugli affitti brevi è il tentativo del legislatore di conciliare esigenze di gettito, tutela degli abitanti e disciplina del mercato turistico: il successo dipenderà però dall’equilibrio delle misure complementari e dalla capacità delle istituzioni di monitorare e adattare le regole ad un fenomeno che resta in rapida evoluzione.
Giulio Benedetti – Studio Benedetti Dottori Commercialisti – www.studiobenedetti.eu – www.travelfocus.it
I blog di TTG Italia non rappresentano una testata giornalistica poiché sono aggiornati senza alcuna periodicità. Non possono pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 07.03.2001. Le opinioni ivi espresse sono sotto la responsabilità dei rispettivi autori.
Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana