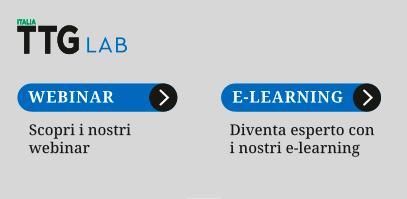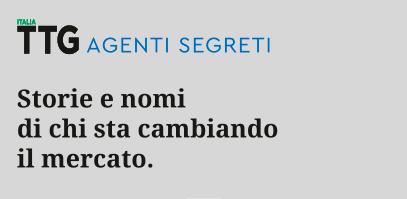Succede che in una giornata d’estate, quando delle vacanze italiane si parla e – soprattutto – si sparla ovunque, si decida di andare a vedere cosa se ne pensasse in passato e come alcuni artisti di fama abbiano nel tempo contribuito, con i loro manifesti, a trasformarle in un mito.
Ne vale la pena, perché nelle sale del torinese Palazzo Madama che fino al 25 agosto ospita circa 200 manifesti promozionali delle più svariate località della nostra penisola*, si tira finalmente un sospiro di sollievo. Tutto appare quieto e silente: gli scorci urbani, montani, costieri e termali di cui si può godere lungo il percorso paiono, al netto della valenza del tratto artistico degli autori, rappresentazioni al limite dell’ingenuo: schiette, sincere, garbatamente eleganti. Salvo rivelare una realtà spiazzante: l’esperienza di cui tanto si è parlato negli ultimi anni, pervicacemente inseguita – secondo molti – da ogni viaggiatore contemporaneo degno di definirsi tale, in realtà è sempre stata presente nell’offerta di viaggio. Era infatti il 1938 quando Giuseppe Riccobaldi Del Bava esortava a visitare “Pompei di Notte” per conto dell’Ente Provinciale per il Turismo di Napoli, anticipando gli eventi notturni che in nome di un accresciuto valore dell’esperienza di viaggio vanno oggi moltiplicandosi. Ed era il 1929 (“circa”, specifica la nota in mostra) quando la creatività di Amos Scorzon corredava l’invito di ENIT ad un’escursione sui “Campi di Battaglia” del monte Sabotino e del Basso Isonzo, precorrendo così l’experience promessa da quel war o dark tourism che di tanto in tanto si riaffaccia. Sempre a inizio ‘900 il Lido di Venezia veniva proposto al mercato francese nel periodo che oggi diremo “di spalla”, quale stazione climatica e balneare ideale anche in primavera ed autunno, con possibilità di frequentare il Casinò e il Circolo Privato. Le Regie Fonti di Recoaro nel 1910 annunciavano invece uno “Stabilimento radicalmente trasformato”, con una quantità di esperienze da fare invidia ancora oggi a molte destinazioni. L’offerta comprendeva infatti - cito letteralmente - “alloggi privati e caffè confortevoli, passeggiate alpestri, cavalcate sui somarelli, ritrovi serali e concerti”. Tutto questo per una “cura climatica delle più apprezzate, per l’aria purissima, per la costanza del cielo e la copia della vegetazione”, anche queste invidiabili certezze ormai tramontate.
Tirate le somme, dunque, il desiderio di vivere nel miglior modo possibile la vacanza e di “esserci” in e con tutti i sensi c’era anche un secolo fa.
E allora, ci si chiede, perché continuare a porre l’accento sull’esperienza come fosse una novità? La risposta, almeno io personalmente, l’ho trovata ascoltando su RaiPlay Sound la puntata estiva di Tutta la Città ne Parla dedicata al viaggio in cui l’antropologo Duccio Canestrini – autore di vari libri sul tema – ha sciolto il nodo, in modo rapido e netto, com’è nel suo stile. Secondo Canestrini la differenza fra il passato e il presente starebbe nel fatto che oggi “l’esperienza turistica è diventata una performance, una prestazione, qualcosa che si fa per poi poter dire che si è fatta”.
“Un comportamento ostentativo” secondo l’antropologo che, mi sentirei di aggiungere, spesso nasce a puro uso e consumo delle nostre personali vetrine sociali e che ben poco ha a vedere con l’esperienza trasformativa che ogni viaggio - ancorché breve – dovrebbe, - ancorché minimamente - attivare.
* Mostra “Visitate l’Italia! Promozione e pubblicità turistica 1900-1950”
I blog di TTG Italia non rappresentano una testata giornalistica poiché sono aggiornati senza alcuna periodicità. Non possono pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 07.03.2001. Le opinioni ivi espresse sono sotto la responsabilità dei rispettivi autori.
Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana